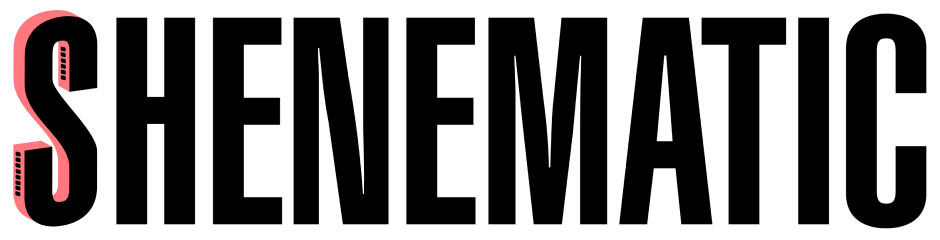Ambientato a New York negli anni Cinquanta, il film del 2015 diretto da Todd Haynes racconta la storia di Therese Belivet, una giovane aspirante fotografa la cui vita viene stravolta dall’incontro con Carol Aird, una donna più grande alle prese con un difficile divorzio e dalla quale la ragazza si sente immediatamente affascinata.
Il punto focale del film ruota attorno alla ricerca identitaria delle due protagoniste, in un’epoca in cui l’individualità femminile era ben lontana dall’essere socialmente auspicabile. Un percorso, quello di Carol e ancor di più di Therese – nel cui caso si può parlare di vero e proprio film di formazione – iniziato, alimentato e veicolato dalle fasi del loro legame affettivo.
Parliamo di una storia d’amore in realtà abbastanza semplice nello scheletro della sua messa in sceneggiatura: l’incontro, l’attrazione, l’ostacolo, lo scioglimento finale. Quello che però rende il film di Haynes particolare rispetto ad altre pellicole che tentano di raccontare un sentimento venuto dal nulla, qual è quello del cosiddetto “amore a prima vista”, è la modalità di messa in scena.

La relazione tra le due protagoniste, così come la loro evoluzione personale, è quasi totalmente costruita sul meccanismo della visione; questo meccanismo riguarda sia le modalità con cui la rappresentazione del desiderio amoroso e sessuale delle due donne viene trainata innanzitutto (e inevitabilmente) dai loro sguardi, ma anche l’apparato formale tramite cui quegli sguardi vengono colti dalla macchina da presa, e quindi, di conseguenza, dallo spettatore.
È proprio questa corrispondenza a definire il nucleo tematico e stilistico di tutto il lavoro del regista americano; una scelta estetica di spiccata eleganza, che diventa persino essenziale se si pensa che Haynes aveva il compito di raccontare il nascere di un sentimento che negli anni Cinquanta era a dir poco impensabile, men che meno dicibile. Carol è infatti un film che a parole ci dice poco, ma che con le immagini dice tutto. Un film in cui l’emozione non deriva dal detto, ma dalla potenza di quello che non viene detto, che sta comunque lì sulla superficie, perfettamente visibile. Basta guardare.

La macchina da presa di Haynes si muove così con lenti movimenti a scoprire, sancendo la presenza di uno sguardo che si fa molteplice, ma tenendosi spesso a dovuta distanza nell’osservare le due donne da dietro porte, finestre o specchi, come a voler preservare la purezza e la dignità di un privato che è invece quasi sempre violato da un contesto patriarcale che non riesce o non vuole capirle. In questo senso, ancor più che un film queer, Carol è un film femminista.
Come detto, però, la pellicola di Todd Haynes è anche e soprattutto una riflessione sull’atto del guardare, esplicitata da quella pulsione scopica che sta alla base di ogni arte cinematografica; e tutte le componenti filmiche – dalla sceneggiatura al montaggio – si piegano saggiamente a questo taglio estetico, lasciando spazio a regista e attrici di costruire visivamente l’essenza della storia.

A tal proposito, merita di essere menzionato l’operato della sceneggiatrice Phyllis Nagy che fa un lavoro eccezzionale nell’adattare il romanzo di Patricia Highsmith (The Price of Salt) al medium cinematografico. Lo fa servendosi di alcune accortezze che possono erronemanete sembrare banali (il personaggio di Therese, nel libro, è una scenografa teatrale), o con strategie testuali più sottili e ricercate.
Nel primo caso il cambiamento da scenografa a fotografa fa sì che la macchina fotografica diventi un surrogato dell’occhio tramite cui Therese può avvicinarsi a Carol; quest’avvicinamento però, almeno inizialmente, avviene attraverso il filtro di un obiettivo fotografico che metaforicamente unisce e divide le due protagoniste.
Nel secondo caso, la struttura circolare della sceneggiatura e il reiterarsi di battute, gesti o scene che riproposte successivamente acqusisciscono un differente significato, segnalano il cambiamento di ruoli e di prospettiva avvenuto nella relazione tra le due donne, e permettono alle immagini di comunicare senza l’intevento troppo invasivo della parola.

In questo contesto, la riuscita del film non può prescidere dalle capacità attoriali delle due pratagoniste: se la bravura e l’intensità di Cate Blanchett non sorprendono, Rooney Mara risponde costruendo il suo personaggio con un’interpretazione tutta in sottrazione, fatta di emozione trattenuta ed espressività controllata, riuscendo nell’intento proibitivo di mostrare ciò che nella diegesi filmica doveva restare celato. Quel qualcosa che ci viene altresì mostrato nei volti delle due donne simbolicamente confusi tra i riflessi.
L’ultima scena, in questo senso, non può che essere un nitido e catartico guardarsi senza più ostacoli: Carol guarda dritto in macchina, verso di noi, e verso Therese. Perché dopo tutto, che cos’è il cinema se non la rappresentazione di uno sguardo?