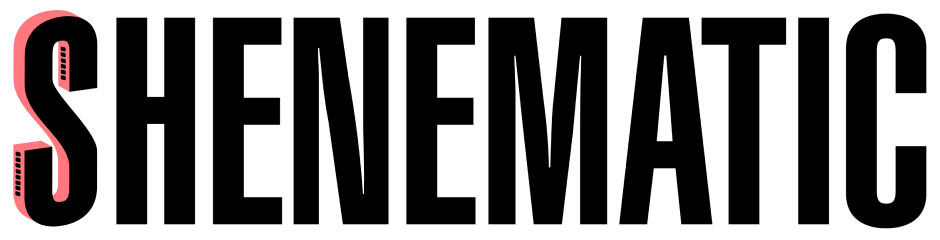Ispirato al bestseller di Eric Jager intitolato “The Last Duel: A True Story of Trial By Combat in Medieval France”, il film di Ridley Scott racconta una vicenda giudiziaria realmente accaduta nella Normandia del XIV secolo. La disputa ruotava attorno all’accusa di stupro che Marguerite de Thibouville rivolse verso Jacques Le Gris, uomo contro cui suo marito Jean de Carrouges era da anni in disputa a causa di prorietà terriere e favori militari contesi. Dopo l’accusa, il marito di Marguerite si appellò al diritto di risolvere il caso attraverso un “processo per combattimento”, una forma di giustizia già allora superata ma non ancora illegale. L’idea si fondava sulla convinzione che Dio non avrebbe permesso alla menzogna di prevalere durante un duello all’ultimo sangue: il vincitore, perciò, sarebbe stato creduto senza alcun dubbio.

Il film inizia proprio con i preparativi antecedenti al duello, per poi tornare indietro nel tempo e raccontarci gli eventi per ben tre volte attraverso la prospettiva di ognuno dei protagonisti. I primi due capitoli, ossia le due versioni maschili della storia (quella del marito e dell’accusato), sono state scritte da Matt Damon (che interpreta de Carrouges) e Ben Affleck. Il capitolo dedicato a Marguerite, ultimo cronologicamente ma centrale dal punto di vista narrativo, è stato invece scritto da Nicole Holofcener, allorché Damon e Affleck – considerando l’argomento – si erano accorti di aver bisogno di una donna per la stesura della prospettiva femminile.
Una struttura tripartita di questo tipo, in questo genere di storia, è senza dubbio interessante ma pericolosa per svariati motivi. Il primo è che si rischia di svilire la versione della vittima portando avanti la tesi secondo cui la verità può anche non essere unica.
Il secondo ha invece a che fare con la controversia di dedicare alle due versioni maschili più della metà del film, marginalizzando la voce di Marguerite ancora una volta.
In questo senso, il rischio è quello di perpetuare l’idea che il punto focale della vicenda non sia la presunta vittima, ma l’accusato o il marito. Marito che al tempo – ricordiamolo – era giurudicamente l’unica parte lesa: il solo reato per cui Le Gris avrebbe potuto subire una condanna era quello commesso contro Jean de Carrouges e non contro Marguerite, considerata legalmente una proprietà del marito.
Il primo aspetto viene risolto da Scott, a torto o a ragione, schierandosi apertamente con la versione della donna. Se i primi due capitoli erano stati anticipati dal titolo “La verità secondo Jean de Carrouges” e “La verità secondo Jacques Le Gris “, nel capitolo dedicato alla donna, la dicitura “La verità” resta da sola sullo schermo per qualche secondo.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, è invece innegabile che confinare il personaggio di Marguerite – vero cuore pulsante della storia – alla parte finale del film, sia stato un freno sia in termini di ritmo che in termini di appeal emotivo, soprattutto nella prima metà della pellicola.

Dei tre capitoli, il primo è quello che per ovvi motivi risulta più sacrificato e meno interessante; a parte fornire il contesto della storia, appare ancora poco comprensibile la scelta di dedicare così tanto tempo ad avvenimenti non inerenti al quesito fondamentale del processo. Già il secondo capitolo su Le Gris, anche grazie a un’interpretazione affascinante di Adam Driver, inizia a essere più godibile, e riconoscendo i primi cambiamenti tonali tra una versione e l’altra si inizia a comprendere il meccanismo del film.
Come detto, la scelta di relegare la voce di Marguerite all’ultimo atto della pellicola può essere non condivisibile per varie ragioni, ma è giusto sottolineare che parte del motivo per cui il suo capitolo acquisisce tanto valore sta anche nel confronto con le due precedenti versioni. L’efficacia dell’ultimo intermezzo è tale anche perché il confronto con i primi due ne potenzia il coinvolgimento.
La prima metà del film, per quanto forse troppo lunga e sicuramente fastidiosa in realazione alla non rilevanza con la vittima in quanto vittima di stupro, ha però rilevanza a posteriori, nell’ottica di Marguerite in quanto vittima sociale, prigioniera di un gioco di potere tra due uomini e condannata ad appellarsi a una giustizia di “seconda mano”. Una giustizia legata solo all’ego del marito e alla sua voglia di rivalsa sociale nei confronti di Le Gris.
È proprio l’ultima parte del film a calcare la mano su questo aspetto, rendendo omaggio alla battaglia di una donna che rischiò la vita pur di non piegarsi e stare in silenzio. Marguerite de Thibouville denuciò infatti lo stupro consapevole che un’eventuale sconfitta del marito a duello l’avrebbe condannata a morire bruciata viva. E proprio quando la celebrazione (più che giusta) che il film fa del suo coraggio poteva rischiare di svilire l’esperienza di quelle donne che non lo hanno avuto e che non sono riuscite in alcun modo a ribellarsi al sistema, ci pensano le parole della stessa Marguerite a fugare ogni rischio in tal senso. Quando la donna – dopo anni di tentativi – riesce ad avere un bambino poco prima del duello, dichiara con rimorso che se l’avesse saputo prima non avrebbe mai portato avanti la sua battaglia rischiando di perdere la possibilità di vederlo crescere.
Sarebbe rimasta in silenzio, come molte donne prima e dopo di lei, ma non per questo meno vittime. E il fatto che il film sia riuscito a sottolinearlo in modo così sottile ma efficace, è un merito non da poco.

È un merito non da poco anche la capacità di Jodie Comer di padroneggiare con classe i cambiamenti tonali e le connessioni concettuali ed emotive tra una versione e l’altra, che in buona parte si reggono grazie alla sua interpretazione. Se la struttura del film riesce nel suo intento senza sfociare nel mero esercizio formale, molto è dovuto alla performance dell’attrice britannica, perfettamente quadrata nella specificità di ogni versione. Comer ha la capacità di giocare sulle sfumature senza risultare eccessivamente finta nelle variazioni o perdere il filo conduttore del suo personaggio. Passa da innocente, a seduttiva, a combattiva in modo sottile, sfruttando la coerenza data dal tumulto interiore di Marguerite. Un tumulto all’inizio mitigato ma sempre presente, fino all’esplosione di vitalità del terzo atto.
Ed è anche grazie a Jodie Comer se Ridley Scott, con la decisione di far vedere lo stupro per ben due volte, schiva il rischio della spettaccolarizzazione in favore di una chiara dichiarazione d’intenti. Le variazioni tra le due percezioni, come al solito, ci sono: non è un caso che quando Le Gris fa irruzione in casa della donna, nel rifiutare le avance dell’uomo, l’attrice scelga di utilizzare un tono sottilmente robotico rispetto alla versione di Marguerite. Ma queste differenze diventano sempre più evanescenti ma mano che ci si avvicina alla scena dello stupro. Per quanto leggermente meno cruda, la violenza nei confronti di Marguerite è senza alcun ombra di dubbio uno stupro anche nella versione di Le Gris. E se in un primo momento ci si potrebbe chiedere che senso abbia far vedere una chiarissima violenza sessuale nella versione che in teoria avrebbe dovuto instillare un qualche dubbio allo spettatore (altrimenti perché ripetere gli avvenimenti per ben tre volte?), il motivo sta nella drammaticità del fatto che quello che noi consideriamo stupro in modo inequivocabile, per le Gris non lo è. Ed è spaventoso.
In fin dei conti, il film di Scott, come detto, non vuole riflettere sulla soggettività o meno delle percezioni individuali o sull’oggettività o meno di un fatto, ma su un quadro storico e sociale in cui Marguerite (e con lei altre donne) è vittima più volte: non solo di stupro, ma anche della cultura che lo perpetua e lo occulta. Una cultura che la priva delle sue libertà fondamentali e la condanna a rivivere il trauma all’infinito nel tentativo di vedere validata la sua verità. Quella della vittima.